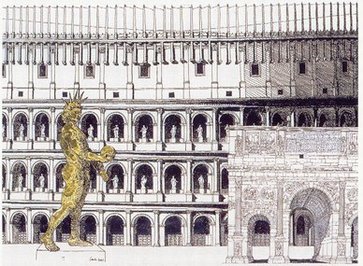
Su Aldo
Rossi
Carlo Aymonino, intervista a cura di
Efisio Pitzalis
EP - Ora, una domanda provocatoria.
Nell'ultimo scorcio dell'attività progettuale, Aldo Rossi incarnava la figura
antonomastica della star: ripreso, ricopiato, scimmiottato da una moltitudine di
esegeti o di epigoni. Molti suoi progetti finali, più che di Aldo Rossi,
sembravano alla Aldo Rossi. Pensi che la consapevolezza di contare su nutrite
schiere di epigoni lo avesse indotto, similmente a De Chirico, a riprodurre da
sé i propri falsi d'autore? Oppure il fastidio verso alcune forzature imitative
lo aveva reso preda di un disincantato cinismo o, al contrario, di un
"aristocratico distacco"?
CA - Innanzitutto bisogna
considerare la ristrettezza di tempo. Pensa soltanto agli ultimi incarichi. Si
tratta di quattro o cinque insiemi di edifici da consegnare in due anni. Quindi
c'è un carico lavorativo incredibile, anche se devo dire che c'è un mistero nel
modo di affrontare una tale mole di lavoro, perché lo studio di Aldo non è come
quello, per esempio, di Zaha Hadid, con trenta persone impegnate al computer, o
di Foster, che ha addirittura tre piani di studio a Londra. Di fatto: lo studio
di Aldo, quello che ha portato avanti la Fenice e l'ha conclusa, alla fine è
costituito da cinque architetti. Quindi: questa organizzazione resta un mistero,
perché in fondo è sempre stato uno studio artigianale, certamente facilitato dal
fatto che, come hai notato tu, negli ultimi tempi c'era ripetizione assoluta.
C'era la trave di ferro che fungeva da piattabanda, eccetera eccetera... Era un
esercizio simile a quello messo in pratica, a suo tempo, da Koch a Roma.
Infatti, secondo una testimonianza di mio zio Marcello Piacentini, che ci aveva
lavorato, Koch elaborava i prospetti e poi diceva: qui un C5 (era una finestra),
qui un B10 (il portone): li montava ed era fatto. Non dico che il caso di Aldo
fosse proprio lo stesso, però sicuramente si trattava di un'artigianalitÃ
organizzata.
Peter Eisenman, intervista a cura di
Flores Zanchi
FZ - Cosa crede sia rimasto, per le
generazioni future, dell'opera di Aldo Rossi?
PE - Le dico cosa penso in generale. Se
Palladio non avesse scritto I quattro libri dell'architettura , noi non
guarderemmo i suoi stupidi edifici e se Le Corbusier non avesse scritto
Verso un'architettura , noi non presteremmo attenzione a quelle piccole
casette bianche, perché in Francia, allora, tutti costruivano piccole case
bianche.
Secondo me i libri trascendono l'architettura e credo che
L'architettura della città di Rossi, come del resto Complexity and
Contradiction di Venturi, trascendano l'opera costruita. I progetti di
Rossi, salvo rare eccezioni, una volta realizzati non erano così rilevanti. I
disegni erano densi di pensiero e di idee molto più dell'edificio e quanto i
suoi scritti. Dunque ritengo che per altri duecento anni leggeremo
L'architettura della città per capire questo nostro periodo storico, ma
non guarderemo le sue costruzioni.
Diane Ghirardo,
intervista a cura di Chiara Visentin
CV - Cosa
ha portato di sè Aldo Rossi in America? Uno stile o un nuovo modo di analizzare
la città ? Come era vista la sua teoria e come era vista la sua architettura?
Vernacolare, postmoderna, storicista o semplicemente una civile lettura del
fenomeno urbano nella sua realtà passata e presente?
DG - Rossi aveva già seguaci negli Stati Uniti ancor
prima che le sue teorie fossero comprese, solo il saggio di Moneo iniziò a farle
comprendere appieno. Di seguito, lo stesso fece il catalogo dello IAUS per la
mostra del '79. Il cimitero presentò un mondo dell'architettura completamente
alieno alla maggior parte dell'architettura americana del periodo. La
pubblicazione del cimitero fu seguita dalla rivista GA, che pubblicò le scuole
di Fagnano Olona e Broni, e altri progetti ancora, attraverso stupefacenti
fotografie. L'esplorazione degli elementi base del progetto - masse in luce o in
ombra, coni, colonne - esercitarono un enorme appeal . Io credo che
fosse in special modo per i disegni, straordinariamente seducenti, che parlavano
del ritorno della poesia verso l'architettura e dei nessi tra edifici come
oggetti grandi e piccolI nella città , di un'architettura non solo diagrammatica,
ma viva e colta. I suoi disegni erano elettrici: non si riescono a produrre
disegni come questi senza l'uso della memoria. Cosa offrì all'America Rossi? Fu
il ritorno alla storia che era stata, fino a quel momento, ignorata o
dimenticata per colpa del Movimento Moderno; chiese a tutti noi di guardarci
indietro, ancora una volta alla storia dell'architettura, ma non, come Venturi,
solamente sul piano formale, bensì attraverso la tipologia, la morfologia, ci
spinse a interessarci ad essa come sequenza di fatti urbani. Un approccio come
questo era ben evidente nel suo progetto del Cimitero, ma era presente, e ancor
più pregnante, nei disegni.
Daniel Libeskind,
intervista a cura di Roberto Dell'Orco
RDO - Lei
dice che l'opera di Rossi è caratterizzata da una specie di anonimato, ma le sue
opere sembrano essere sempre chiaramente riconoscibili
DL -
Certo, perché non è un anonimato formale. Si riconosce la firma di Rossi anche
nel più banale dei suoi edifici, un dettaglio, un muro, perché il suo non è un
anonimato della forma, è un riflettersi dell'anonimato della forma nella sua
personalità , è la profonda passione per una dimensione spirituale. E' ciò che lo
distingue dai suoi imitatori, dalle finestre quadrate e da tutto il banale
ciarpame di quel tipo. In Rossi conta la sostanza interna della architettura, la
logica con cui sviluppa la sua opera dal rilevante al banale. Il banale diventa
interessante quando tu ne riesci a vedere l'aspetto meno visibile, una
dimensione che cresce fino all'anonimato di cui dicevo, fino al non voler essere
architetto, fino ad accettare l'imperfezione della vita.
Spesso Rossi mi
diceva: "Io e te non dovremo fare gli architetti, avremmo molto più successo se
facessimo film o scrivessimo libri, o ancor più se non facessimo niente,
semplicemente vivendo". Aveva capito molto bene il problema della dimensione
caricaturale che l'architettura assume nelle riviste, portata nei media...
Renzo Piano, intervista a cura di Claudia
Conforti
RP - Tutto cominciò quando ad Aldo diedero il
premio Pritzker. Spinto da un impulso a cui non era estraneo l'orgoglio
nazionale, gli scrissi di getto due righe, congratulandomi con entusiasmo. Aldo
rimase un po' sconcertato, perché noi non ci conoscevamo: nel senso che non ci
eravamo mai incontrati, né scritti. E anzi molti ritenevano che le nostre
differenze espressive registrassero una contrapposizione personale. Non era
così, naturalmente. In seguito Aldo mi telefonò per ringraziarmi, e così
cominciammo a frequentarci, soprattutto a Parigi: pranzavamo insieme, veniva in
studio, gli chiedevo dei consigli.
Specialmente su come fare le finestre:
perché, lo confesso, io non sono mai riuscito a fare delle finestre convincenti,
mentre Aldo sapeva fare finestre perfette, bellissime! Naturalmente su queste
cose ci piaceva scherzare. Credo che in sostanza quello che ci univa, e che
rendeva i nostri incontri tutt'altro che episodici, fosse in primo luogo il
comune tratto caratteriale: quel che i francesi definiscono gentil mais
insupportable , cioè cocciuto, testardo; poi c'era anche quella sua
attitudine a smontare le cose. Anche io tendo a smontare le cose. Certo, le
smontiamo in modo diverso: Aldo smontava la memoria delle cose, la loro immagine
acquisita, fissata nell'immaginario, e lavorava su quella. Io invece smonto
materialmente le cose, come fanno i ragazzini quando smontano la radio,
riducendola in mille pezzi. Aldo invece smontava l'immagine della radio. Però il
procedimento è lo stesso: prima smontare l'oggetto, farlo a pezzi, poi
rimontarlo a modo nostro. C'era in noi questo comune atteggiamento dell'
artisan furieux , l'artigiano un po' pazzo, che ha bisogno di smontare
e rimontare appassionatamente gli oggetti per conoscerli e possederli...
Paolo Portoghesi
PP - In questi
anni a cavaliere del nuovo millennio è cresciuta la marea delle obliquità , il
culto della autoreferenzialità , l'indifferenza per il contesto urbano e la
voglia di meravigliare ad ogni costo con il virtuosismo tecnologico e l'abilitÃ
funambolesca nell'uso del computer. Eisenman, colpito dalla smania del
ciceroniano "repuerascere" (illudersi cioè di tornar bambini) teorizza ormai la
giungla come sfondo del proprio operare e progetta cicatrici e rocciose
emergenze ricavate nel ventre della terra, Frank Gehry, una volta attento
osservatore del vissuto di una America marginale, assorta nella sua poetica
quotidianità , si è specializzato nella creazione di aggrovigliate matasse di
fettucce metalliche che ricordano le lamiere contorte delle automobili travolte
dagli incidenti stradali. Zaha Hadid, uno degli ultimi acquisti dello
star-system, premio Pritzker per il 2004, continua imperterrita a realizzare le
sue noiose sculture inabitabili, ricorrendo all'aiuto di solerti ingegneri per
tenere in piedi strutture contrarie ad ogni logica costruttiva, necessarie di
rinforzi e riparazioni prima ancora di essere inaugurate come è successo per la
stazione dei pulmann di Strasburgo.
Assistere a questo spettacolo di
retrocessione e involuzione mascherato da vitale ripresa dei temi della
modernità , sarebbe stato penoso per chi, come Rossi, aveva contribuito alla
critica della modernità con raro equilibrio, conscio che c'era molto da salvare
nella sua eredità , purchè se ne superassero le illusioni e le false certezze.
Purtroppo è mancato in questi anni difficili il suo apporto critico, anche
se le ultime opere da lui progettate fedelmente portate a termine dai suoi
"giovani di studio" hanno continuato ad arricchire il panorama delle sue
esperienze e ci hanno consegnato una immagine del suo lavoro non come qualcosa
di concluso e di omogeneo ma come qualcosa di non finito, di aperto, di
irriducibile a una formula rassicurante. E qui c'è da dire che non ci convince
per niente la tendenza di alcuni dei suoi esegeti a contrapporre a una fase
purista fondativa e inattaccabile, una fase sperimentale arrischiata e meno
ricca di conquiste teoriche e di virtualità didattiche. Se la distinzione in
periodi della sua opera progettuale è del tutto legittima ed ha come suo
fondamento le riflessioni della "Autobiografia scientifica", una
contrapposizione qualitativa mi sembra fuori luogo e c'è da augurarsi che si
torni a riflettere sulle ultime opere come un lascito ancora in gran parte da
interpretare. E' proprio in esse, nella loro sapiente urbanità che si può forse
oggi trovare una risposta alla marea dilagante delle architetture anti-urbane,
una alternativa all'ottimismo solipsistico che così spesso degenera in
compiaciuto narcisismo,in una cultura della continua interrogazione.
Un
aspetto profondamente attuale della eredità teorica che Aldo ci ha trasmesso è
certamente il discorso sull'ordine e sul "teatro della vita"...
Fabio Reinhart, intervista a cura di Annalisa
Trentin
FR - La "Città analoga" nasce come opera
collettiva perché Aldo voleva che il modo di produrre l'immagine corrispondesse
alle idee che l'immagine stessa doveva esprimere. Pensò ai suoi ex-assistenti a
Zurigo. Noi abbiamo allargato la partecipazione a Eraldo Consolascio, con il
quale c'erano dei lavori in comune. Insieme abbiamo stabilito procedura e
tecnica. Si tratta di un collage di xerox, fotografato su pellicola e stampato
con una tecnica ottocentesca detta "Plandruck" a Zurigo e "gelatina" in Italia.
Misura 2 x 2 m.
Di comune accordo si è posto il primo punto fisso: dal primo
colpo d'occhio la composizione doveva apparire in movimento, disporre di un
motore e di un centro di rotazione. Poi si decise chi, o cosa, mandare in scena:
il territorio, le diverse forme d'esistenza della città , i solidi platonici,
oggetti d'affezione. Stabilito il "cosa fare", si passò al "come fare". Si
organizzò la struttura della tavola risalendo alla sera del terzo giorno della
Genesi: in basso sono le acque (testura ricavata da un manuale d'idraulica
dell'800) dalle quali emergono le terre (uno stralcio della prima carta
topografica svizzera); a quel frammento di rilievo prealpino si sovrappongono la
città reale (il rilievo tipologico di Como), la città della memoria (la Roma di
Piranesi), la città ideale (quella di Cesariano).
Non trovammo intesa circa
le immagini da attribuire al perno della composizione e al "motore primo".
L'accordo era solo di fondo: doveva essere "un che di polisemico". Per superare
l'ostacolo ci recammo a Milano. Quale incipit Aldo propose il viso androgino del
Davide di Tanzio da Varallo. Il trapianto di una nuova mano con l'indice rivolto
al centro della composizione lo liberò dalla testa di Golia e dall'identità . Ora
chi era? Un angelo? La Giovinezza? La Bellezza? Per il centro Aldo non avanzò
proposte, ma fu categorico: - Non può essere una architettura!...
Ettore Sottsass, intervista a cura di Davide
Vargas
ES - Stimavo molto Aldo Rossi, uno dei pochi
architetti italiani contemporanei che hanno un senso, una certa compattezza; si
diceva che fosse comunista o fascista, io trovavo invece che era un uomo di
grande sensibilità e di grande poetica.
Intanto veniva dalla "letteratura",
era laureato in lettere, aveva una cultura che andava al di là della cultura
tecnica spicciola professionale.
Per un architetto è già cosa abbastanza
interessante che la propria cultura vada più verso l'uomo che verso
l'ingegneria.
A parte questo, avevo visto un libro sull'architettura
popolare padana, architettura contadina, e questo mi ha fatto molto pensare:
Aldo Rossi era interessato a trovare una specie di noce di base nella gente e
riconoscere la qualità di una architettura, molto semplice, molto compatta,
molto legata al paesaggio, con attenzione.
L'architettura popolare è spesso
una speciale combinazione tra le necessità fisiche e il loro posizionamento
nell'ambiente, la cura dei materiali, una certa purezza o semplicità di
composizione che poi non è solo rintracciabile nell'architettura ma investe
anche le aie, i muretti, la stradina che arriva nel posto giusto e così via.
Un lavoro da architetto diciamo, e Aldo Rossi era molto attento a questi
procedimenti, a questi metodi.
Eduardo Souto de Moura,
intervista a cura di Antonio Esposito
ESM - Poi ci
fu un altro seminario, quello organizzato da Rossi a Santiago, al quale
partecipai insieme a un gruppo di studenti di Porto. Lavoravamo con gli
assistenti, secondo degli schemi molto rigidi, quasi monastici nella
organizzazione e nello svolgimento del lavoro, mentre noi portoghesi eravamo in
un momento di euforia rivoluzionaria. Così, assieme ai sivigliani, contestammo
tutto e demmo atto a una sorta di insubordinazione; volevamo discutere il
progetto direttamente con Rossi. Rossi arrivò, ben vestito, di ottimo aspetto, e
ci stette ad ascoltare, finché a un certo punto ci disse "Avete pienamente
ragione, ma a me non interessa. Ciò che mi interessa è che voi riusciate a
spiegare le vostre ragioni. L'unica cosa che importa in architettura è provare
di avere ragione. Io vi do ragione, ma voi dovete dimostrare di averla." Fu un
grande insegnamento che ha condizionato enormemente il mio lavoro.
Un'altra
cosa per me memorabile di quel seminario, fu la lezione che egli tenne
sull'architettura industriale, sulla sua mancanza di intenzionalità , sull'essere
quel che è. Rossi parlò un'ora e mezza con tre diapositive, con un rigore
assoluto; nella sala buia lui leggeva il testo con una piccola luce.
Tornai
carico da quella esperienza, convinto di poter osare; feci pure una ricerca
tipologica sulla città di Porto. Ricordo che parlai con Siza, a lungo, del
seminario e di Rossi e lui mi propose di fare, l'indomani, una lezione su Rossi
nel suo corso.
Così accettai e descrissi l'esperienza di Santiago e le mie
impressioni positive su quello che durante il seminario definivamo il sistema
"tipo-topo-morfo" per la relazione stretta tra la tipologia, il luogo e la
forma. All'epoca poteva essere una definizione con qualche senso ironico o
denigratorio, che oggi assolutamente non le attribuisco.
In quei mesi
cominciava a prendere forma il mio dramma: Siza e Rossi erano gli architetti che
apprezzavo di più e io capivo che non andavano d'accordo, sebbene si
rispettassero molto.






